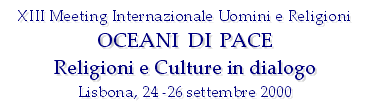|
In apertura del mio intervento, desidererei ringraziare i
miei amici della Comunit´┐Ż di Sant'Egidio per la tenacia di perpetuare la
tradizione delle riunioni internazionali "Uomini e religioni".
E' senz'altro un onore per me trovarmi qui, in una cos´┐Ż distinta
compagnia. Penso che la mia presenza a Lisbona ricorda l'Incontro di
Bucarest - organizzato due anni fa - come anche il desiderio degli ospiti
ospitanti di ascoltare le voci degli europei dell'Est sempre pi´┐Ż
presenti, si potrebbe asserire, nel dibattito dei problemi che il mondo
contemporaneo deve affrontare. Mi sia consentito di parlare di alcune
cause che ci impediscono di poter salutare, ancora, la manifestazione
dinamica e plausibile di una vera "anima" europea.
Come si sa la storia culturale dell'Europa ´┐Ż cosparsa di metafore
anatomiche. Questo fatto retorico segna, secondo me, la permanenza di
alcune nostalgie organiciste, ma anche l'influenza effettiva del Nuovo
Testamento, nelle cui pagine la Chiesa - la societ´┐Ż umana potenzialmente
perfetta - ´┐Ż descritta come Corpo di Cristo. Non far´┐Ż qui nemmeno la
bozza di questa storia immaginaria, lungo la quale il vocabolario barocco
- pensiamo a Sant'Agostino e alle sue "ginocchia del cuore" - si
coniuga con il simbolismo gerarchico dei vari organi. Ho fatto una
semplice allusione alla rispettiva tradizione anatomica, solo per mettere
in prospettiva la metafora di cui ce ne occupiamo in questa sede: l'anima
dell'Europa. Il semplice fatto che descriviamo l'energia delle nostre
societ´┐Ż come "un'anima" dimostra che gli antichi dibattiti
teologici - da cui si ´┐Ż plasmata la coscienza europea - sono
sostanzialmente attuali, al di l´┐Ż del loro formalismo desueto. Mirata con
attenzione, questa ricerca di una "anima" europea suppone alcune
premesse di natura critica: 1. Prima di tutto mi sembra che l'Europa abbia
gi´┐Ż un "corpo", ma che a questo corpo manchi una dinamica
psicologica e una risorsa "animatrice" di consenso civico. 2. In
secondo luogo abbiamo il sentimento che le difficolt´┐Ż della costruzione
europea siano causate dall'assenza di un ideale in grado di completare le
politiche comunitarie mediante l'associazione di nazioni equilibrate. 3.
Insomma risentiamo l'esigenza di "umanizzare" i rapporti tra gli
organismi europei e gli attuali o i futuri cittadini dell'Unione. Queste
tre supposizioni - particolarmente serie - ci mostrano che "la
volont´┐Ż di anima" palesata in seno alle societ´┐Ż europee non sia una
licenza poetica: abbiamo a che fare con una problematica direttamente
collegata alla nostra vita, cos´┐Ż come essa si svolge qui e adesso. Chiedo
il permesso di riflettere, prima di tutto, sulle sopra ricordate premesse.
La prima sostiene che - per varie ragioni storico-ideologiche - i popoli
europei non sono pi´┐Ż beneficiari di un principio spirituale unificante.
L'Europa si riduce ad una impersonale esteriorit´┐Ż funzionale che provoca
un vuoto teleologico, una carenza di quegli scopi spirituali nell'assenza
dei quali qualsiasi impresa umana scivola in una scialba inutilit´┐Ż. Essa
produce merci, cultura di consumo e trattati, ma non significati
collettivi e neanche motivazioni individuali. Evidentemente, non possiamo
pretendere agli organismi europei di "generare" una
spiritualit´┐Ż comunitaria. Possiamo per´┐Ż esigere il superamento di quella
modernit´┐Ż sotto il cui impatto il politico ha soffocato il religioso,
considerando che il progresso non pu´┐Ż avere luogo che contro le Chiese
cristiane. Se questo comportamento critico non impregner´┐Ż la mentalit´┐Ż
degli eurocrati, allora il deficit di spiritualit´┐Ż verr´┐Ż compensato con
nuovi surrogati, di ispirazione settaria-fondamentalista o neoideologica.
Ci sarebbe bisogno di un Concilio Vaticano II anche a Bruxelles, dato che
parlare semplicemente di postmodernit´┐Ż non ´┐Ż sufficiente per sbarazzarsi
dai dogmi di un'epoca, dalla superstizione della onniscienza
programmatrice e dall'ipocrisia dell'umanesimo astratto. Mediante
un'operazione di purificazione concettuale quelli che decidono oggi il
destino dell'Europa non favoreggerebbero oggi un nuovo clericalismo e
tanto meno le temibili derive fondamentaliste, quanto un'aperta
riflessione che sa fruttificare la tradizione, rispettando nel contempo il
potenziale democratico dell'autentico impegno religioso.
La seconda premessa critica a cui facevo riferimento denunciava l'assenza
di un ideale comunitario. Dopo la seconda guerra mondiale gli stati
europei occidentali hanno capito che sar´┐Ż possibile non dichiararsi
reciprocamente la guerra, solo a patto che sappiano reprimere il proprio
"nazionalismo". Questo compito ´┐Ż stato semplificato
dall'esistenza della guerra fredda che metteva davanti a loro un
avversario ossessivo e, per cos´┐Ż dire, unitario. Dopo il 1990 il
tentativo degli stati ex-comunisti di riaffermare la propria dignit´┐Ż
nazionale ´┐Ż stata subito demonizzato nell'Occidente. Ulteriormente e fino
a pochi giorni fa i Governi dei quattordici stati dell'UE hanno ritenuto
che fosse pi´┐Ż facile sanzionare economicamente tutta l'Austria, invece di
chiedersi quali fattori psico-sociali abbiano garantito l'ascesa di Jorg
Heider e quali fossero i metodi per arrestare - sin da principio - tali
manifestazioni politiche. Il problema ´┐Ż che alle nazioni ´┐Ż stato chiesto
di superare il nazionalismo, ma non ´┐Ż stato detto loro con che cosa lo
potessero sostituire. Per loro, l'Europa ´┐Ż la somma di alcune istituzioni
che non prolungano in modo organico la vita degli stati, ma si colloca -
in maniera tendenziale - al di sopra di essi. Da un grandioso mezzo
pacificatore e civilizzatore, il processo di costruzione dell'Unione
Europea si ´┐Ż trasformato in uno scopo indipendente, pi´┐Ż simile alla
linea dell'orizzonte, che ad una meta poliedrica di un percorso razionale.
L'inerzia del pensiero politico utopistico ´┐Ż forse colpevole della nostra
pessima relazione con lo spazio europeo. Invece di considerare l'Europa
un'associazione qualitativa di stati democratici e l'armonizzazione
complessa di patrimoni nazionali distinti, abbiamo spesso l'impressione
che il futuro del continente circoscrive un altrove verso cui ci spostiamo
insieme, uscendo dalla nostra matrice originaria. L'attuale vulgata della
costruzione europea preconizza una Nuova Europa, una specie di terza via,
sospesa tra il rinnegamento della memoria e l'ingegneria futurologica
della pragmatica transazionistica. Una tale costruzione non regger´┐Ż
perch´┐Ż non si pu´┐Ż costruire una casa su fondamenta annullate e non si
pu´┐Ż neanche garantire la struttura portante, se il progetto viene
modificato ogni dieci anni. Si addice trovare nel passato dell'Europa non
solo crimini ed errori che devono essere evitati d'ora in poi, ma anche
ottiche e valori che possono ispirare il progetto delle generazioni
emergenti. Oggid´┐Ż, l'Europa ´┐Ż soffocata da una cultura della
colpevolezza. Tutto quello che hanno fatto i nostri predecessori sembra
condannabile, eccessivo, respingente e - quindi - inutilizzabile. Per
compensare il deficit di idealit´┐Ż in cui soccombiamo, sarebbe auspicabile
la costituzione di una cultura della vergogna, in cui la nozione di onore,
l'orgoglio di essere europeo, ispiri la pratica di una garbatezza morale a
slancio filantropico e comunitario.
Menzionavo, in fine, l'esigenza di "umanizzare" i rapporti tra
gli organismi dell'Unione e i suoi cittadini. Non mi riferivo
all'eccessivo richiamo alla democrazia diretta e alla sostituzione del
parlamentarismo classico con un sistema (populista) di consultazione
referendaria. Pensavo all'obbligo di lanciare messaggi semplici che
lascino posto alla carit´┐Ż, ai sentimenti fondamentali, ai bisogni reali,
cos´┐Ż come li viviamo nell'intimit´┐Ż della famiglia, del nostro cerchio di
amici, o all'interno della nostra comunit´┐Ż locale. Le necessit´┐Ż della
gente vengono effettivamente sepolte dalle perizie astratte che limitano
la passione dell'umanit´┐Ż alla proiezione elettorale e confonde la
pulsione vitale con la normalit´┐Ż della condizione di consumatore. Sono
stati prodotti tanti gerghi impenetrabili, tanta perizia specializzata,
tante stereotipe formule statistiche e categorie globali, che il cittadino
dell'Europa - membro di una nazione, erede di un patrimonio locale ed
esponente di una certa sensibilit´┐Ż confessionale - si sente a buona
ragione abbandonato, separato, ignorato. Perch´┐Ż meravigliarci, allora,
della sua apatia, assenza allo scrutinio europeo, convinzione che tutto
quel che accade nelle capitali dell'Unione ´┐Ż irrimediabilmente distante?
Per rovesciare la tendenza, si raccomanda l'applicazione effettiva del
principio di sussidiariet´┐Ż, il decentramento amministrativo, la
riabilitazione della dimensione locale, il radicamento nel suolo specifico
di ciascuna comunit´┐Ż.
Riassumendo il discorso finora fatto, potremmo pretendere: 1. La dignit´┐Ż
di una missione europea con particolarit´┐Ż geopolitiche e spirituali
distinte. 2. La riabilitazione delle identit´┐Ż nazionali, nella misura in
cui le nazioni sono i componenti irriducibili della futura compagine
continentale. 3. L'accettazione dell'idea che la persona umana e le sue
creazioni immateriali non devono essere ridotte a degli stimoli
economico-finanziari di un mercato completamente sregolato. Se queste
richieste fossero adempite, i nostri successori seguiterebbero uno scopo,
le nazioni supererebbero la tentazione dell'etnocentrismo, e i cittadini
di ciascuno stato membro ritroverebbero il desiderio di partecipare alla
vita politica dell'Unione.
Quest'analisi dei fattori che impediscono la formazione di una
"anima" europea sarebbe incompleta se ci limiteremmo a divulgare
la crisi di idealit´┐Ż, la forza de-strutturante del sentimento
anti-nazionale e l'eccesso burocratico degli organismi comunitari.
L'Europa ha ancora almeno altri due problemi dalla cui cattiva gestione
risulta un paesaggio generale confuso ed inerziale. Il primo problema ´┐Ż
ovviamente quello del dislivello economico. Il secondo riguarda il dilemma
del dialogo ecumenico, cio´┐Ż l'altalena tra un pluralismo confessionale
acefalo e una tendenza di un pi´┐Ż antico monolitismo confessionale,
tradotto sia con chiusure nazionaliste, sia con l'orchestrazione di un
proselitismo insidioso. Esaminiamole, in conclusione, brevemente.
Il problema del dislivello economico non ´┐Ż (soltanto) una questione di
prodotto interno lordo o di rata dell'inflazione, ma anche una di cultura
della solidariet´┐Ż europea. E' chiaro che non possiamo dettare ai ricchi
la ridistribuzione delle proprie risorse. Ma non potremmo neanche
costruire l'Europa su una differenza di standard cos´┐Ż acuta. Molti
occidentali considerano che l'Est aspetti elemosina, anche se ci´┐Ż si
appella al modello dell'antico piano Marshall o ai pi´┐Ż recenti programmi
tipo PHARE. Non ´┐Ż per niente vero. Ci sono naturalmente nell'Est delle
categorie sociali impregnate da attese assistenzialiste. Ma ci sono anche
nuove generazioni professionali che possiedono competenze purtroppo non
utilizzate a causa della carenza di capitale. La graduale omogeneizzazione
del continente si realizzer´┐Ż alla confluenza tra la dinamica del mercato
libero e l'espressione di una decisa volont´┐Ż politica, che non dovrebbe
nascondersi dietro slogan generosi, essendo destinata piuttosto a produrre
un veritiero progetto di ricostruzione e sviluppo est-europeo. Fino a
quando gli Stati di questa regione saranno abbandonati alle mere
evoluzioni interne, senza un influsso di finanziamenti controllati, il
dislivello economico inibir´┐Ż l'integrazione economica, e il ritardo
dell'integrazione politica acuir´┐Ż quelle fratture dell'immaginario
europeo comparse durante la guerra fredda. Una quotidiana pratica del
partnership, una rete di sinergie regionali, un comportamento politico
solidale e equo romperanno questo circolo vizioso. Fortunatamente, dopo il
summit di Helsinki del dicembre 1999 - e nella prospettiva del prossimo
vertice di Nizza, alla fine di quest'anno - ci sono segnali positivi che i
Governi occidentali intendono mobilitarsi per passare ai fatti, aumentando
simultaneamente la velocit´┐Ż, l'ampiezza e la qualit´┐Ż dei processi di
integrazione. Non possiamo che apprezzare questo ravvivamento, assicurando
nel contempo i nostri amici occidentali che - nonostante le apparenze -
troveranno nell'Europa orientale sufficienti persone con cui si potr´┐Ż
lavorare in modo efficiente.
Per quel che riguarda l'ultimo problema enunciato - quello dell'ecumenismo
- considero che ci´┐Ż non concerni esclusivamente le relazioni tra i
vescovadi delle varie Chiese. L'ecumenismo - cio´┐Ż il fenomeno della
graduale riconciliazione tra tutti i cristiani, prima di tutto europei -
interpella la coscienza di qualsiasi persona, matura dal punto di vista
storico ed educativo. Infatti tutte le difficolt´┐Ż enunciate nel mio
intervento si rispecchiano, alquanto, nella questione religiosa. Costruire
una civilt´┐Ż dell'amore significa forse chiedere troppo dalla natura umana
i cui limiti sono da tempo e incessantemente verificate. Ma tendere verso
una tale civilt´┐Ż senza tenere conto dell'insegnamento di Ges´┐Ż Cristo e
senza rispettare - anche con la cauzione di alcune definizioni mobili -
gli imperativi morali inerenti al Vangelo, significa stagnare nel
perimetro dell'arbitrario etico e della demagogia sterile. I padri
fondatori dell'Unione Europea pensavano da cristiani. E' normale che la
loro posterit´┐Ż non si possa mantenere mediante il rifiuto iperlaicista
dell'eredit´┐Ż che ci hanno trasmesso e neanche tramite la permissivit´┐Ż
caotica del turbocapitalismo monopolista. Ecco perch´┐Ż il tema della
riconciliazione tra le Chiese supera la sfera della spiritualit´┐Ż e della
religione istituzionale e si riflette nel complesso di quei valori che gli
europei hanno generato, mettendole tante volte a repentaglio: il rispetto
della persona umana e della vita stessa, la codificazione dello spazio
pubblico, la garanzia della pace, l'armonizzarsi delle diversit´┐Ż, la
gerarchizzazione delle competenze nella prospettiva della sussidiariet´┐Ż,
l'approfondimento dell'esercizio democratico e la compassione di fronte a
qualsiasi sofferenza ingiusta, ecco altrettanti principi e atteggiamenti
che riceverebbero una maggiore consacrazione tramite il negoziarsi di
nuovi rapporti con le nostre proprie radici. E' difficile da affermare
oggigiorno, in pieno riaggiustamento post-moderno, post-industriale e
post-comunista, quale sarebbe la fisionomia esatta di una christianitas
rigenerata. Possiamo per´┐Ż essere sicuri che, per acquistare una
"anima", l'Europa dovr´┐Ż non temere pi´┐Ż le parole compromesse
dai nostri predecessori in modo volontario o casualmente. Imparando di
nuovo quelle parole, tornandovi con la snellezza della nostra eterna
curiosit´┐Ż, comprenderemo che - talvolta - l'affermazione della propria
identit´┐Ż ´┐Ż sinonimo con l'educazione dei nuovi barbari, quale che fosse
il loro nome o le ambizioni con cui si avvicinassero alle frontiere della
civilt´┐Ż che desideriamo salvare.
|