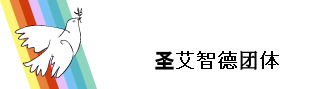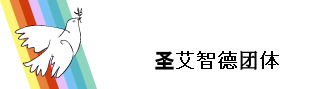Nel Novecento, per il cristianesimo, pochi giorni sono storici come il 5 gennaio 1964. Cinquant'anni fa, Paolo VI e il Patriarca ortodosso di Costantinopoli, Atenagora, si incontrarono e si abbracciarono a Gerusalemme. Il 6 gennaio il Papa rese la visita al Patriarca. Si chiudeva quasi un millennio di scomuniche e d'incomunicabilità. Era una svolta. A Roma, in pieno Concilio, il Papa aveva annunciato il prossimo pellegrinaggio in Terra Santa di fronte ai vescovi stupiti. Il viaggio aveva un valore simbolico: il ritorno alle origini evangeliche. Mai il Papa era uscito dall'Europa cristiana. Invece visitava un mondo in cui i cristiani erano minoritari: Gerusalemme e Betlemme sotto controllo della Giordania musulmana; la Galilea e la periferia della Città Santa, parte d'Israele. Con entrambi gli Stati, la Santa Sede non aveva rapporti diplomatici. Il Papa si incontrava per la prima volta con l'ebraismo e lo Stato ebraico. L'avrebbero acclamato le folle musulmane.
In un quadro così nuovo, arrivò la proposta di Atenagora: incontrarsi a Gerusalemme, dove entrambi i leader si sarebbero fatti pellegrini. Atenagora è una delle più grandi figure del cristianesimo del Novecento. Tra gli scontri nazionali della fine dell'impero ottomano e le guerre, aveva maturato una visione ecumenica: la rinnovata unità dei cristiani come fermento dell'unità dei popoli. Amava ripetere: «Chiese sorelle, popoli fratelli». Patriarca di Costantinopoli dal 1948, guidava una piccola comunità greca in difficoltà nella Turchia laica. Ma aveva assunto una vera leadership ecumenica. Cercava l'unità tra le Chiese ortodosse, divise dalla Guerra fredda e da logiche nazionalistiche, soprattutto con il patriarcato di Mosca. Da molti anni proponeva rapporti nuovi con i cattolici. Con Giovanni XXIII, erano cominciati i contatti tra il Vaticano e il Fanar (la modesta sede del patriarcato a Istanbul). All'annuncio del viaggio papale in Terra Santa, Atenagora capì che una svolta era possibile.
Il 10 dicembre 1964, arrivò a Istanbul da Roma il padre Duprey, infaticabile tessitore di rapporti con il Patriarca. I problemi erano tanti. Da più di novecento anni esisteva una rottura totale determinata dalle scomuniche del 1054. I tentativi di unione successivi restavano un cattivo ricordo per gli ortodossi, che li consideravano frutto dell'imperialismo romano. Ma ora lo scenario era diverso: il Papa e il Patriarca si potevano incontrare sullo stesso piano, riconoscersi vicendevolmente come cristiani. Iniziava quello che Atenagora chiamava il «dialogo dell'amore». L'abbraccio tra i due Primati è l'icona di una nuova stagione ecumenica che dura tuttora.
Per la prima volta un Patriarca ortodosso (considerato spesso come scismatico dall'opinione cattolica) entrava nell'immaginario cattolico accanto al Papa. L'ecumenismo diventava popolare, nonostante le resistenze da ambedue le parti. In cinquant'anni si è molto avanzato dal punto di vista del dialogo teologico e dei rapporti quotidiani. I cristiani, pur ancora divisi, si sentono ormai parte di una stessa grande comunità. Tuttavia tra ortodossi e cattolici resta una frattura insanata, come si vede dal fatto che l'Eucarestia non viene celebrata insieme. Sono possibili ulteriori passi? Atenagora avrebbe voluto un'accelerazione ecumenica, mentre Paolo VI - dopo l'incontro di Gerusalemme - ebbe la sensazione che una svolta verso l'unità fosse vicina. Ma non si conciliano facilmente mentalità e teologie sviluppatesi in modo separato per quasi un millennio. Tuttavia oggi, di fronte al mondo globalizzato, va riproposto il problema della divisione dei cristiani. Lo sviluppo, velocissimo ed esteso, di comunità cristiane neoprotestanti, frammentate e penetranti, pone la questione del valore dell'unità, come caratteristica delle Chiese cristiane. È il problema se non si debba valorizzare il tanto che unisce i cristiani piuttosto quanto ancora li divide. Oggi resta attuale il monito di Atenagora: «guai se i popoli raggiungessero un giorno l'unione al di fuori delle strutture e della teologia della Chiesa». Per lui sarebbe stata un'unificazione senz'anima. Questo fa riflettere noi, generazione della globalizzazione.